DI CHRISTIAN PAROLIN
[PER LEGGERE LA PRIMA PARTE DEL RACCONTO, CLICCA QUA SOPRA!!!]
V
Li lasciai cadere sul pavimento, come se scottassero. Ero senza parole. Davanti ai miei occhi avevo la prova che la mia ragazza mi tradiva. Avrei potuto accettare di tutto: una lettera d’amore, magari inviata da un amico o da qualche ragazzo che le stava appresso; un fiore, un braccialetto o un anello. Sciocchezze che si regalano che devono restare nascoste. Ma due preservativi! Come avrei potuto giustificarli? Nei casi sopra citati, l’ombra del tradimento carnale ci sarebbe potuta essere, ma non era ovvio; due preservativi erano la prova lampante che si scopava un altro.
Sentii dei passi svelti e pesanti salire le scale dell’androne. Raccolsi i preservativi e li misi dentro il portafoglio, lo appoggiai dove l’avevo trovato e mi allontanai di corsa verso la cucina. Sentii che cercava di infilare le chiavi dentro la fessura, ma sembrava talmente agitata da non riuscirci. Andai ad aprirle la porta.
«Scusa, ho dimenticato il portafoglio» disse con il fiatone. Dalla sua faccia sconvolta si evinceva l’agitazione che la tormentava.
Allungai la mano per prendere il portafoglio, e la vidi irrigidirsi. Avrei giurato di veder scendere dalla sua fronte una goccia di sudore.
«Tieni» le dissi.
Lo prese e la sua mano tremava.
«Grazie».
Poi, prima di uscire, mi mise una mano dietro al collo e mi diede un bacio a stampo. Le sue labbra si appoggiarono appena sulle mie. Si voltò e uscì.
Quel bacio confermò tutte le mie paure.
VI
Dentro di me mi sentivo bruciare. Una fiamma che mi urlava di andare a fondo di quella storia. Ero furioso e demolito. I tradimenti li avevo letti nei libri e visti nei film, al massimo vissuti sulla pelle di conoscenti, ma quando scoprii che stava capitando a me, mi sembrò che gli anni vissuti prima di allora non contassero più niente. L’intera mia esistenza si era ridotta al momento in cui presi in mano il portafoglio e scoprii quei due preservativi. Mi sforzavo di trovare una soluzione, ma non sapevo nemmeno a quale problema. Se se la stava facendo con un altro non c’era niente che avrei potuto fare. Era stata una sua scelta, sulla quale sicuramente io avevo influito, ma non avevo la possibilità di farle cambiare idea o di dimostrarmi migliore. Di chi, poi?
Tornai in cucina. In frigo vidi una banana mezza nera. La presi. Poi presi il pancarrè, il burro d’arachidi e un coltello piatto. Tirai fuori tre fette di pane dal sacchetto e ci spalmai il burro. Aprii la banana e la tagliai a fettine sottili, le misi sopra le fette e cominciai a mangiare. Speravo che mangiare mi distraesse, ma era inutile. Più deglutivo, più mi accorgevo di non avere per niente fame; anzi, era probabile che avrei vomitato tutto. Non avevo mai visto nessuno del corso di disegno. Forse li invitava mentre io non c’ero. Era inverosimile pensare che non ci fossero ragazzi al corso. Forse addirittura uomini. Alla mia ragazza erano sempre piaciuti quelli più grandi; le piacevano alti, belli robusti, con la barba folta e il viso attempato. Uomini. Io avevo appena ventitré anni, non andavo in palestra e non avevo l’aurea di sicurezza che poteva avere un uomo. Se mi fossi trovato nella situazione di competere avrei perso in qualsiasi caso.
Finii le fette con la banana e rimisi a posto il barattolo di burro d’arachidi. Quel movimento mi costò fatica; non avevo più energia. Mi risedetti. Mi veniva da piangere, ma forse mi veniva troppo da piangere, e allora non ci riuscivo. Avrei voluto andare a prenderla e affrontarla, avrei voluto rimanere a casa e affogare nella mia disperazione. In quel momento ero così confuso che non sapevo più chi ero io e per quale motivo stavo vivendo. Corsi in bagno e vomitai.
Erano le tre e quarantacinque. Non mi aveva mandato nessun messaggio e non aveva chiamato. Guardavo prima il telefono e poi l’orologio, telefono e orologio, telefono e orologio. Stavo andando fuori di testa. Dovevo uscire da quell’appartamento o sarei impazzito.
Andai in camera e aprii l’armadio. Ne avevamo uno solo e lo dividevamo, ma io avevo così poche cose che era praticamente tutto suo. Cominciai a sbirciare tra i suoi vestiti. Passai la mano tra le felpe, i pantaloni, i cappelli. Mi sembrava che tutto fosse messo lì per ricordarmi che lei c’era ma non era più mia. Presi una tuta e sbattei l’anta.
Fuori faceva freddo. Era uggioso, grigio, senza un raggio di sole e con il vento che soffiava calmo ma costante. La giornata meno indicata per andare a dipingere in mezzo ai campi.
Guidai fino in centro. Non sapevo per quale motivo, ma era l’unico posto, al di fuori di casa, dove mi sembrava di essere a casa. Parcheggiai vicino al cinema.
Ero travolto dall’ansia. A stento riuscivo a coordinare i passi e camminavo affondando una gamba sui sampietrini e spostando l’altra a destra e a sinistra. C’era molta gente e mi sentivo a disagio. Mi fermai davanti alle strisce e aspettai il verde. A fianco avevo una coppia di ragazzi. Avranno avuto quindici anni. Si tenevano per mano e si parlavano a voce bassa. Mi arrivava solo qualche frammento, ma erano cose come scuola, compiti, professori, festa, lo facciamo. Avrei dato tutto pur di tornare alla loro età. Non conoscevo ancora la mia ragazza ed ero senza pensieri. La scuola non mi pesava perché non mi importava nulla; non studiavo, spesso non mi presentavo. Avevo alcuni amici con i quali fumavo le sigarette all’uscita e bevevo quasi tutte le sere. Da quando avevo preso a lavorare in tessitoria mi pentivo di non essermi impegnato a scuola. L’università mi sembrava fuori portata, ma almeno con il diploma avrei avuto qualche speranza. O almeno non sarei stato trattato come una bestia.
Scattò il verde.
Mi infilai sotto i portici e mi trovai la strada sbarrata da un gruppo di ragazzine. Erano poco più piccole di me. Una di loro mi guardò e tenne gli occhi puntati per tutto il tempo mentre passavo loro accanto. Io pensavo solo che la mia ragazza mi tradiva.
Rallentai il passo e mi girai verso i tavolini dei vari bar. Scrutavo ogni volto per riconoscere il suo. Arrivai alla fine della piazza, e quindi dei bar, senza averla vista. Forse non avevo guardato bene, o forse mi aveva visto e si era nascosta o se n’era andata. Non volevo tornare indietro, e quindi attraversai la strada e andai dentro i giardini del centro. Erano il luogo adatto alle coppiette, specialmente ai ragazzini.
Ero quasi dall’altra parte, quando, dalla cima della collinetta guardai in basso. C’erano due panchine, una di fronte all’altra, coperte dalle chiome di vari piccoli alberi che sorgevano a ridosso delle panchine. Vidi una massa rosa sventolare davanti ad un uomo. Gli occhi mi si inumidirono. Scesi dalla collinetta in punta di piedi. Più mi avvicinavo, più le loro voci si facevano chiare. Mi sedetti sulla panchina dietro ad un grosso albero, poco distante da loro, e cercai di carpire quello che si dicevano. Lui aveva una voce profonda, sembrava molto più vecchio di me. Mi girai a guardarlo, incuriosito. Aveva i capelli biondi e ricci legati in una coda, la barba sotto le mascelle e il mento e gli occhiali rotondi che gli ingrandivano gli occhi. Fisicamente sembrava grassoccio e non molto alto. Non era il suo prototipo. Era vestito tutto di nero e indossava un impermeabile blu scuro. La punta delle sue scarpe era coperta di fango. Mi chiesi cosa avesse quell’uomo di bello. Guardai anche lei. I capelli erano dello stesso colore, ma c’era qualcosa di strano. La mia ragazza non era magra come quella che stavo guardando. Non aveva zaino né borsone, e aveva un giubbotto viola. In casa non c’era nessun giubbotto viola. Pensai che forse dentro il borsone aveva messo dei vestiti di ricambio e si fosse cambiata a casa di quell’uomo. Li osservai. Lui aveva un grande sorriso, e quando rideva si muoveva avanti e indietro con il corpo. Lei rimaneva ferma, ma sentivo la sua risata. Non era lei. Un po’ sollevato decisi di alzarmi e di proseguire verso l’uscita. Presi un vecchio fazzoletto che trovai in tasca e lo gettai nel primo cestino che vidi, e con la scusa mi voltai verso quei due. Il mio cuore riprese a battere quando mi accorsi che la ragazza dai capelli rosa portava gli occhiali. La mia ragazza non li aveva. Continuai a fissarla per assicurarmene, ma non era lei. Con un gran sollievo, mi diressi verso l’altra parte dei giardinetti.
Questa era la parte più privata, o almeno, a me aveva sempre dato quella sensazione, perché era dietro la piazza ed era più piccola. Le prime panchine erano tutte vuote. Continuai a camminare. Vidi una signora che portava il cane al guinzaglio, un vecchietto che camminava ricurvo, e un paio di bambini che correvano mentre il padre gridava loro di stare attenti. Nel mio futuro, mi immaginavo io, lei e due figli, un maschio e una femmina dentro una casa con un grande giardino. Io e lei eravamo seduti sotto il piccolo portico a bere vino, mentre i nostri bambini si rincorrevano e ridevano. Il sole scendeva, e io mi giravo verso mia moglie e la baciavo e le sue labbra sapevano di vino rosso. Ci guardavamo negli occhi, con la pelle invecchiata, e ci dichiaravamo amore. Tornai alla realtà quando uno dei due ragazzi mi venne addosso.
«Scusa» disse con la sua vocina mentre mi guardava con il labbro all’ingiù e una paura tremenda negli occhi. Io gli scompigliai i capelli e gli sorrisi. Lui ricambiò e tornò dal fratellino. Attraversando il giardino, incrociai il padre che mi chiese scusa a nome di suo figlio. Gli sorrisi e gli feci un cenno con la mano.
Attraversai il ponte che passava sopra le fosse e camminai sul marciapiede. Lì non c’era. Non sapevo se esserne felice o preoccupato. Ero più preoccupato che felice. In cuor mio desideravo coglierla in flagrante. La conferma del mio dubbio sarebbe stata più facile da sopportare che il dubbio. Proseguii e arrivai ad un altro semaforo. Era rosso, quindi rallentai e mi guardai intorno. Era tutto tranquillo in quella parte di piazza, e sarebbe stato un pomeriggio gradevole se non fosse stato per la nebbia. Proprio nel punto dov’ero io, sulla destra c’erano degli scalini che portavano ad una panchina di pietra nascosta dalla strada. Ci andavo per bere di nascosto quando ero alle superiori. Vidi una figura femminile muoversi. Vidi solo una scarpa, ed era una classica Vans nera con la striscia bianca. Erano le scarpe con le quali era uscita la mia ragazza. Non significava niente, dal momento che quelle scarpe le aveva chiunque. Decisi comunque di indagare. Capii che erano un ragazzo e una ragazza. La voce di lui mi sembrava giovane, non da ragazzino ma neanche da uomo. Lui le parlava di una sua partita di calcio in cui aveva fatto un bel gol eccetera, ma ciò che attirò la mia attenzione fu la risata di lei: era la stessa identica risata della mia ragazza. Cominciai a sentire il viso arrossarsi e il corpo tremare. Aspettai per avere conferma. Quando la sentii chiedere a che ora fosse tornato a casa, mi lanciai senza pensarci due volte.
«Perché?» gridai. Mancai gli ultimi due scalini e non caddi per miracolo.
Quello che mi trovai di fronte non era ciò che mi aspettavo. Una criniera nera e un viso di giovane donna sorpresa. Il ragazzo si alzò e mi affrontò un po’ titubante. Rimasi paralizzato, con i rivoli di sudore che scorrevano dietro le orecchie mentre la ragazza si teneva aggrappata al suo busto.
Balbettai qualcosa e filai di corsa sul marciapiede.
L’omino diventò verde. Attraversai la strada pieno di vergogna. Decisi di tornare a casa. Ero stanco, mi girava la testa e sentivo dietro l’angolo una crisi di pianto.
Salii le scale del condominio con le gambe pesanti. Non volevo entrare. Non volevo stare da solo con i miei pensieri; piuttosto sarei andato a chiedere di lei a chiunque avessi incontrato. Con il braccio moscio, infilai la chiave e girai.
Venni accolto da un profumo dolce, di torta al forno. Le luci della cucina erano accese e di sottofondo c’era musica country, la sua musica preferita. Ero confuso. Mi tolsi il giubbotto e lo appesi dietro la porta. Restai lì a pensare a niente in particolare, solo rimasi fermo a guardare il soffitto. Con le narici piene di aroma di arancia, alzai la testa ed entrai in cucina.
VII
Indossava un pigiamino rosa corto e attillato, che lasciava fuori l’ombelico. Era in piedi che rigirava qualcosa sulla piastra. Aveva i capelli sciolti che le ricadevano sulle spalle nude. La luce fioca emanata dalla lampadina che penzolava dal soffitto le abbronzava la pelle. Era bella come sei anni prima.
Si girò e mi regalò un sorriso con quei suoi denti meravigliosamente distanti.
«Ho pensato di farmi perdonare» disse.
Il profumo di arancia veniva dal forno, mentre sui fornelli intravedevo della carne.
Si accorse che sbirciavo.
«Ho infornato una torta alle mele e qui sto cucinando una tagliata. Nel microonde ci sono delle patate e poi qui» e si spostò dall’altra parte «sto preparando degli spinaci».
Mentre parlava, mi chiedevo come facesse ad avere un corpo così snello e sodo nonostante non l’avessi mai vista praticare attività fisica. Non mangiava molto, ma nemmeno in modo sano.
Posò la pinza e venne verso di me. Mi cinse i fianchi e mi diede un bacio sulla guancia.
«Scusa se ultimamente non sono stata molto presente».
Avrei voluto sputarle addosso tutto quello che pensavo, ma aveva preparato la cena, per la prima volta dopo chissà quanto tempo, e l’atmosfera sembrava distesa. Ero sicuro che mi sarei pentito se avessi rovinato il momento.
«Non preoccuparti» dissi e l’abbracciai.
Rimanemmo avvinghiati per poco, poi lei si ritrasse e tornò in cucina.
«Com’è andata la vostra escursione?» chiesi un po’ per curiosità, un po’ per provocare.
«Bene, non era il massimo come giornata».
«Cos’hai dipinto?».
«Niente di che. Gli alberi, qualche animaletto».
«E dove siete andate?».
Si girò e mi guardò sorridente, ma non era un sorriso allegro.
«Mi stai facendo il terzo grado?».
«Sono soltanto curioso».
Il forno trillò. Si voltò, indossò il guanto in stoffa e tirò fuori una teglia alta e lunga. La torta fuoriusciva e dei pezzetti di mela si intravedevano incastrati nell’impasto. Aveva un aspetto delizioso. La posò sopra il panno del bancone, rimise il guanto sull’apposito gancio che avevo attaccato al muro e girò la carne.
«Quindi?» dissi.
«Quindi?» rispose senza guardarmi.
«Dove siete andate?».
Rimase in silenzio per qualche secondo.
«Su» disse. «Abbiamo trovato un posticino un po’ isolato e ci siamo fermati lì».
Mi accorsi che utilizzò la parola “fermati” e non “fermate” e glielo feci notare.
«È la stessa cosa!».
«Ci sono anche maschi al corso?».
Lei continuava a darmi le spalle.
«Che importa?».
«Nulla, sono solo curioso».
«Sì, ci sono alcuni uomini. È normale».
«Già».
Da dov’ero io, la bistecca sembrava pronta. Ma lei era immobile a fissare i fornelli, con la mano che reggeva la pinza posata sul banco.
«Credo sia pronta» dissi.
Lei si destò e spense il gas, senza controllare che la carne fosse effettivamente pronta. La prese e la servì sul piatto più grande che avevamo, cioè poco più grande di uno normale. Prese le patate dal microonde e le mise in una ciotola e sistemò tutto sopra il tavolo. La bottiglia di vino era mezza vuota.
Si sedette e io feci lo stesso. Eravamo uno di fronte all’altra, come due estranei qualsiasi.
Cominciò a tagliare la tagliata e mise sul piatto il suo pezzo. Io presi l’altro. Versai il vino sui rispettivi bicchieri, e lei ne bevve subito una lunga sorsata.
La carne era ben cotta, un po’ bruciacchiata sulla superficie.
Mangiammo in silenzio per alcuni minuti. Non avevamo la tv lì in cucina; quella in salotto era troppo piccola ed era in una posizione in cui non si vedeva dal tavolo. Presi una cucchiaiata di patate. Erano quelle del supermercato. Buone, super condite.
Erano le sette e cinque minuti.
«A che ora sei tornata?».
«Alle cinque e mezza».
«Hai pranzato?».
«Abbiamo mangiato al sacco. Alcune ragazze avevano portato del cibo, e prima di andare ci siamo fermati a comprare qualcosa».
Avevo la sensazione che fosse da un’altra parte. Parlava, ma era come se non parlasse con me.
«Io sono andato a fare un giro in centro».
«Com’era?».
«Come sempre. Grigio, pieno di gente. Gli stessi bar, gli stessi negozi, le stesse macchine».
«Mmh».
Iniziai a sentire un cattivo odore. Odore di qualcosa che bruciava. Mi girai verso i fornelli e vidi che la pentola degli spinaci stava andando a fuoco.
«Gli spinaci!».
Tolsi la pentola e la gettai sul lavandino, poi spensi il gas. Gli spinaci erano completamente neri, si rompevano al solo contatto con la forchetta. Buttai via tutto, e mi girai verso la mia ragazza.
«Cosa?» mi disse con l’espressione più intrisa di veleno che le avessi mai visto. Sembrava l’avessi appena accusata di aver distrutto la macchina. Ne avevamo una, ma lei di solito prendeva l’autobus o si faceva scarrozzare dalle amiche.
«Ti sei dimenticata di spegnere il fuoco per gli spinaci».
«Capita!».
«Certo che capita, non ti ho mica detto niente».
«Mi hai guardata come se ti avessi appena distrutto la macchina!».
Tornai a sedermi. Giocai con la mia parte di tagliata con la forchetta. Non avevo più fame. Quel giorno, se si escludevano le fette di pane con il burro di arachidi vomitate, avevo mangiato solo a colazione. Ma la sola vista del cibo mi faceva venire i conati. Anche lei sembrava aver perso l’appetito. Prese il telefono e cominciò a scrollarlo. Io la guardavo impotente. Ero consapevole di aver perso qualsiasi potere su di lei, se mai ne avessi avuto. Non potevo fare niente per sistemare le cose. Mi sentivo morire.
Andai a letto alle nove. Mi sentivo esausto. Non mi feci nemmeno la doccia. La mia ragazza aveva deciso di rimanere a guardare un po’ di tv in salotto. Non mi ero impegnato a dissuaderla né avevo dimostrato il mio disappunto. Annuii e basta. Presi il libro dal comodino e lessi le prime frasi. La mia testa era sommersa, non capivo una parola di quel che leggevo. Ad un certo punto sentii la suoneria di un telefono. Era il suo.
«Ehi» la sentii dire con una dolce voce bassa.
Mi drizzai immediatamente a sedere. la porta era socchiusa, e la camera relativamente vicina al salotto, ma parlava così piano che non sentivo nulla. Mi alzai e indirizzai l’orecchio sulla fessura tra la porta e lo stipite.
«Non molto, non avevo granché fame».
«Sì, mi sono divertita da matti».
«Certo, quando vuoi».
Facevo fatica a decifrare le sue frasi, però riconobbi il modo di parlare. Era lo stesso che aveva con me quando iniziammo a frequentarci.
«No, no».
«Domani non lo so. È domenica».
«Lo so che di solito non facciamo niente, ma metti che gli salta in testa di proporre qualcosa. Dovrei accontentarlo almeno una volta».
«Lo so, ma cosa posso farci?».
Più ascoltavo, più mi sentivo mancare la terra da sotto i piedi. Quando senti dire dalla tua fidanzata, che conosci da sei anni e con cui sei fidanzato da tre, che deve “accontentarti ogni tanto” fa male. Fa davvero male. Molto spesso mi sono immaginato un tradimento per goliardia, per capire come mi sarei comportato. Mi sono sempre detto che non sarebbe stata la fine del mondo, che il mondo era pieno di ragazze e che il dolore, con il tempo, si sarebbe affievolito. In quel momento, con la tempia premuta contro la porta, in pigiama e scalzo capii che, se avessi perso lei, avrei perso tutto. Non avevo amici, lavoravo dalla mattina alla sera dentro un capannone che detestavo, cinque giorni a settimana; vivevo in un bilocale che a malapena potevo permettermi e l’unico passatempo che mi concedevo era leggere libri.
Se avessi perso lei, avrei perso tutto.
VIII
Mi svegliai il lunedì con gli occhi che pulsavano. Avevo dormito sì e no due ore. Mi girai verso il lato destro, dove di solito dormiva lei, e mi accorsi che era vuoto. Allungai la mano, e il cuscino non c’era. Come se mi avessero appena rovesciato un secchio d’acqua gelida, mi alzai e accesi la luce. Le coperte erano intatte, così come il lenzuolo. Mi vestii di fretta e andai in salotto. Stava dormendo rannicchiata su sé stessa, con le ginocchia che sporgevano dal divano. I capelli le coprivano la faccia, e le sue spalle si alzavano e abbassavano con regolarità. Il telefono era collegato al caricatore, che a sua volta era collegato alla presa accanto alla porta.
Mi venne da piangere.
Bevvi una tazzina di caffè, mangiai qualche fetta di pane con il burro, mi lavai i denti e il viso e andai al lavoro.
Per strada trovai parecchio traffico dovuto ad un incidente. Una macchina ne aveva tamponata un’altra, e una terza, per evitare di tamponare la macchina che aveva tamponato quella davanti, aveva sterzato ed era finita fuori strada. Era con il muso piantato dentro un fosso. Non sembrava ci fossero vittime, ma c’era l’ambulanza e una barella era montata di fianco ad essa. Immaginai di sdraiarmici sopra.
Arrivai al capannone con quindici minuti di ritardo. Il caporeparto non c’era, e gli altri erano già con il capo chino sui rotoli di stoffa. Mi sistemai sulla mia postazione e cominciai a lavorare.
Dalla fretta, avevo dimenticato di prepararmi il pranzo e quel pomeriggio non mangiai niente. Arrivarono le cinque e mezza che ero in uno stato di deperimento. La testa mi girava all’impazzata e qualsiasi rumore, anche il più sordo, mi mandava in bestia. Corsi fuori senza salutare nessuno. Non mi accorsi nemmeno di essere montato in macchina, averla messa in moto ed aver guidato fino a casa.
Parcheggiai e scesi, e dovetti reggermi alla cappotta per non cadere. Forse ebbi un calo di pressione, o forse era la fame, ma avrei battuto i denti sull’asfalto se mi fossi trovato un metro più in là rispetto alla macchina. Chiusi gli occhi e respirai a fondo, poi mi diressi verso l’ingresso.
Le luci erano spente e non sentivo nessun rumore. Guardai in ogni stanza, ma erano tutte vuote. Non seppi spiegarmi la collera che mi montò dentro. Corsi in cucina e tirai fuori le prime cose che mi capitavano a tiro. Mangiai wurstel, sottilette, olive sott’olio, un pezzo di formaggio, una confezione di prosciutto cotto e sopra il tavolo trovai qualche frittella. Mi sedetti e mi godetti la sensazione di avere la pancia piena. Bevvi un sorso d’acqua e recuperai piano piano le facoltà mentali. Ricordai che al lunedì c’era il corso di disegno. Il giorno prima, domenica, non avevamo fatto niente. Io ero rimasto a casa a leggere e a guardare la tv, mentre lei aveva alternato il telefono al disegno. Pranzammo e cenammo ad orari diversi.
Mi feci una doccia e mi distesi sul divano. Avevo ancora parecchia fame. Decisi che avrei ordinato una pizza. Avrei potuto farle una sorpresa, ma le sorprese erano un’arma a doppio taglio e quello era il momento meno indicato per rischiare.
«Pronto».
Capii che ero l’ultima persona che avrebbe voluto sentire.
«Pensavo di ordinare una pizza, che ne dici?».
«Stasera non ceno a casa, andiamo a mangiare fuori noi allievi. Era da un po’ che pensavamo di farlo».
«È da un po’ anche che non mangiamo una pizza insieme».
Non so perché lo dissi. Non avevo intenzione di attaccarla.
«Non cambia niente se la mangiamo domani».
«Certo. Buon divertimento».
«Grazie» e chiuse la chiamata.
Ero da solo, in una cucina angustiante sotto una luce gialla e fioca che la metteva ancor più in ombra. Ordinai una capricciosa.
Tornò a casa alle dieci meno un quarto. Io ero già a letto. Appena sentii la porta aprirsi, mi vestii e andai da lei. Avevo intenzione di chiederle scusa per essere stato così scorbutico. Sapevo che in realtà non avevo niente di cui scusarmi, ma mi sentivo di farlo. Avrei dato tutto me stesso per sistemare le cose.
Vidi che teneva lo zaino ancora in spalla e non si era tolta il giubbotto. La seguii in cucina.
«Volevo chiederti scusa».
«Per?» disse con la bocca piena. Mi guardava con impellenza.
«Per esserti sembrato maleducato al telefono. Quello che volevo dire era che mi sarebbe piaciuto».
«Ti spiace se ne parliamo in un altro momento?» mi disse, e senza aspettare una risposta mi oltrepassò e afferrò la maniglia della porta d’ingresso.
Io mi girai senza dire una parola.
«Sono tornata per prendere il caricabatterie e per mangiare un boccone. Mi fermo a dormire da un’amica».
Rimasi in silenzio e immobile, come scioccato.
«Anche stasera?» dissi, ma senza risentimento o rabbia. Ero calmo, spaventosamente calmo.
«Quante altre volte ci sono andata?» disse a voce alta.
«Mi sembra che ultimamente siano aumentate».
«Già, scusa se, a differenza tua, mi piacerebbe continuare ad avere degli amici».
«Non mi ami più? È questo che stai cercando di dirmi?».
«Scusami?».
«Hai un altro?».
«Ma che stai dicendo?».
«Dimmelo!» afferrai il vaso di ceramica sul mobiletto e lo scagliai a terra.
La vidi sussultare. Mi guardò con la faccia di un cane bastonato. Tremava, di rabbia e di paura, credo. Mi pentii immediatamente di quel gesto. Non ero mai stato un ragazzo incline alla rabbia, ma non riuscii a contenermi.
«Sei pazzo!».
Se ne andò sbattendo la porta. Io rimasi fermo.
Stavo impazzendo?
Mi lasciai cadere su una sedia in cucina. Poi mi rialzai e raccolsi i cocci del vaso. Li buttai e mi risedetti. Mi scese qualche lacrima, ma non piansi. Presi il telefono, mosso dall’esigenza di chiamarla per spiegarle il malinteso. Rispose la segreteria. Riprovai. Segreteria. Provai di nuovo. Sempre la segreteria. Avevo bisogno di parlarle. Ma c’era la segreteria.
Passai il resto della sera e tutta la notte seduto su quella sedia. All’inizio perché speravo che tornasse, poi perché non riuscivo a muovere un muscolo del mio corpo. Lei non tornò.
Alle cinque, mi alzai dal tavolo e mi cambiai, e poi filai al capannone.
IX
Era venerdì quando il caporeparto entrò nel capannone alle quattro e ci disse che la giornata finiva lì.
«Per quale motivo?» chiese la donna più vecchia.
«Non c’è più materiale. Questa settimana non sono arrivati i rotoli di stoffa. Hanno parlato di un contrattempo. Comunque, per oggi avete finito. Ci vediamo domani e vediamo cosa fare».
La notizia non mi fece né caldo né freddo. Ogni giorno entravo da quel cancello e non vedevo l’ora che arrivasse sera per tornare a casa, ma poi entravo così tanto dentro il vortice della produzione che quasi mi dispiaceva smettere.
In quei giorni io e la mia ragazza non ci parlammo. La vedevo soltanto la sera, quando tornava a casa da chissà dove. Andava in bagno, si lavava e poi se ne stava in salotto fino a che non finivo di mangiare. Poi si preparava la cena. Dormiva sul divano. Io rimanevo sveglio fino alle due, due e mezza sperando che venisse a letto. Ero tentato di chiamarla e implorarla di dormire con me, ma avrei peggiorato le cose.
Entrai nel parcheggio condominiale e vidi che il mio posto era occupato da una BMW bianca opaca. Non me ne intendevo di auto, ma quella macchina aveva l’aria di essere costosa. Parcheggiai in uno dei due posti di riserva. Scesi e mi avvicinai alla BMW. Era pulita, senza un graffio o un’ammaccatura. Misi le mani a paraocchi e mi affacciai verso i finestrini, stando attento a non toccarli. Vidi i sedili in pelle marrone chiaro, uno schermo grande quanto un tablet al centro del cofano. Lo stemma bianco e blu luccicava sul volante rivestito. Guardai anche dai finestrini posteriori, e dalla mia gola uscì un suono di stupore che temetti si fosse udito in tutto il condominio. Sui sedili c’era il borsone blu della mia ragazza. Era aperto e tutto spiegazzato. Non potevo crederci. Cercai altro, ma non c’erano vestiti o scarpe sparsi. Il mio corpo era percorso da tremolii e respiravo molto in fretta. In casa mia c’era un altro uomo, l’amante della mia ragazza. Mi venne paura a salire. Camminai, superai il cancelletto, percorsi il vialetto, salii le scale e mi piazzai davanti alla porta. Rimasi lì, cercando di sentire qualche rumore o voce proveniente dall’interno. Non sentivo niente. Introdussi la chiave nella serratura, aprii la porta e la richiusi, il tutto nel più lento e silenzioso dei modi. Mi rimisi le chiavi in tasca, mi sfilai le scarpe e in punta di piedi avanzai. In salotto non c’era nessuno, in cucina neanche. In bagno non vedevo luci e la porta della camera era aperta. Perlustrai ogni spazio, ma non trovai nessuno. Inizialmente mi sentii meglio, poi però pensai che, se non erano in casa, erano da qualche altra parte, e non importava dove fossero, perché in qualunque caso erano insieme.
Quel cambio di programma mi scombussolò. Fuori era buio. Il fatto che fossero le quattro di pomeriggio mi metteva una tristezza tale che mi toglieva qualsiasi voglia di fare. Anche alzarmi e prepararmi un caffè diventava un’agonia. Costruii una montagnetta di polvere sul filtro, riempii d’acqua la caldaia e misi la moka sul fornello. Accesi il gas e aspettai. Notai che il lavello era vuoto. Aprii la credenza e la confezione di pancarrè era nell’esatta posizione in cui l’avevo lasciata la mattina. In frigo, il barattolo di burro d’arachidi era nella stessa posizione. La mia ragazza non aveva fatto né colazione né pranzato a casa. Il caffè salì e alcune gocce bagnarono il ripiano. Le ripulii subito prima che si seccassero e lasciassero la macchia. Versai il caffè nella tazza e mi sedetti.
Ero intento a finire l’ultimo sorso mentre leggevo le ultime notizie sul Quotidiano online, che dalla porta entrò la mia ragazza. Aveva lo zaino in spalla e il borsone. Lo stesso borsone che avevo visto sulla BMW. Appena mi vide, fece un saltino e si portò una mano sul petto.
«Dio! Mi hai spaventata».
Erano le cinque.
«Che ci fai a casa a quest’ora?».
Aveva il fiatone e i capelli scompigliati.
«Non c’era materiale e ci hanno mandati a casa prima».
«E sarai a casa anche domani?».
Forse lei lesse qualcosa sulla mia faccia, perché aggiunse: «Giusto per sapere».
«Dobbiamo presentarci alle otto e mezza, ma non so se lavoreremo o meno».
«Oh».
Si tolse giubbotto e scarpe e andò in camera. Ingollai il rimasuglio del caffè e la seguii.
Stava svuotando il borsone.
«Tornando a casa ho trovato un’auto parcheggiata al mio solito posto».
«Sì, era della mia amica. Mi ha dato uno strappo a casa».
«Potevi farla salire per un caffè».
«L’ho fatto».
«Ah; quando sono tornato non c’eravate».
«Siamo andate a fare una passeggiata».
Notai che aveva gli aloni di sudore sotto le ascelle.
«Avete corso o camminato?».
Si toccò la maglietta sotto le braccia e si passò una mano sulla fronte.
«Abbiamo camminato abbastanza».
Gettò il borsone nell’armadio e andò in bagno. Si fece la doccia e uscì dal bagno in jeans e maglione. Stavo per chiederle se fosse in procinto di uscire ancora, ma poi mi ricordai che giorno era.
«Ti devo preparare la cena?».
«Ti chiamo più tardi, quando finisce il corso».
Si infilò le scarpe e uscì di fretta. Si tastò più volte la tasca del giubbotto.
Aspettai qualche minuto, poi andai in camera e presi il suo borsone. Controllai dentro, nelle varie tasche, in cerca di un indizio, di una prova. Non trovai nulla. Andai in bagno e guardai sul cesto dei panni sporchi. C’erano il reggiseno, le mutande, la maglietta sudata. Tornai in camera e aprii il primo cassetto del comodino della sua parte di letto. Trovai dei disegni, alcuni braccialetti e foto di lei con la famiglia e gli amici. Guardai nel secondo. C’erano la sua biancheria, canottiere, magliette varie. E sotto tutto quanto una scatoletta verde topazio. La presi e la agitai. La aprii e trovai un paio di orecchini. Erano due diamanti di colore grigio con sfumature azzurre, come un indeciso cielo nuvoloso, della grandezza di una nocciola. Pesavano. Dovevano essere costosi. Me li rigirai tra le mani, ma non ci capivo nulla di gioielli. Li rimisi nella scatola e rimisi la scatola sotto tutta la sua biancheria. Se li aveva comprati lei, per quale motivo non indossarli la sera e addirittura tenerli nascosti in quel modo? Mi tornò in mente la BMW nel parcheggiò. Troppi soldi.
Mi preparai un’insalatona di tonno per cena. Mangiai da solo, seduto sul divano davanti alla tv. Il telegiornale diceva sempre le solite brutte cose. Non mi piaceva guardarlo, ma mi faceva sentire parte di qualcosa.
Lavai la ciotola e lessi qualche pagina seduto in cucina. Alle dieci mi cambiai e andai a letto. Sulla barra delle notifiche nessun messaggio.
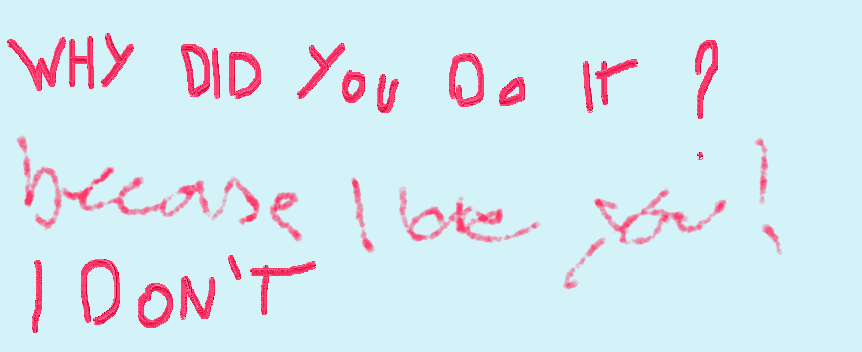
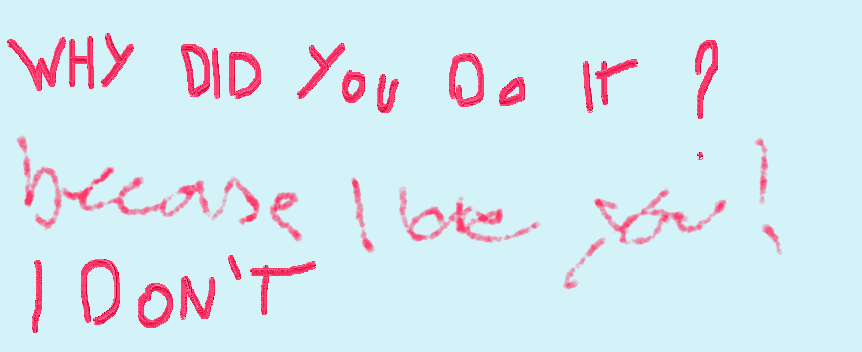
Ti farebbe felice leggere altri racconti? Allora premi qua sopra!!!
Vuoi leggere un articolo che ti parla di che cosa sia l’amore? Clicca qui!!!
Vuoi leggere un articolo che parla di un film che narra una storia d’amore reale? Pigia qua!!!




