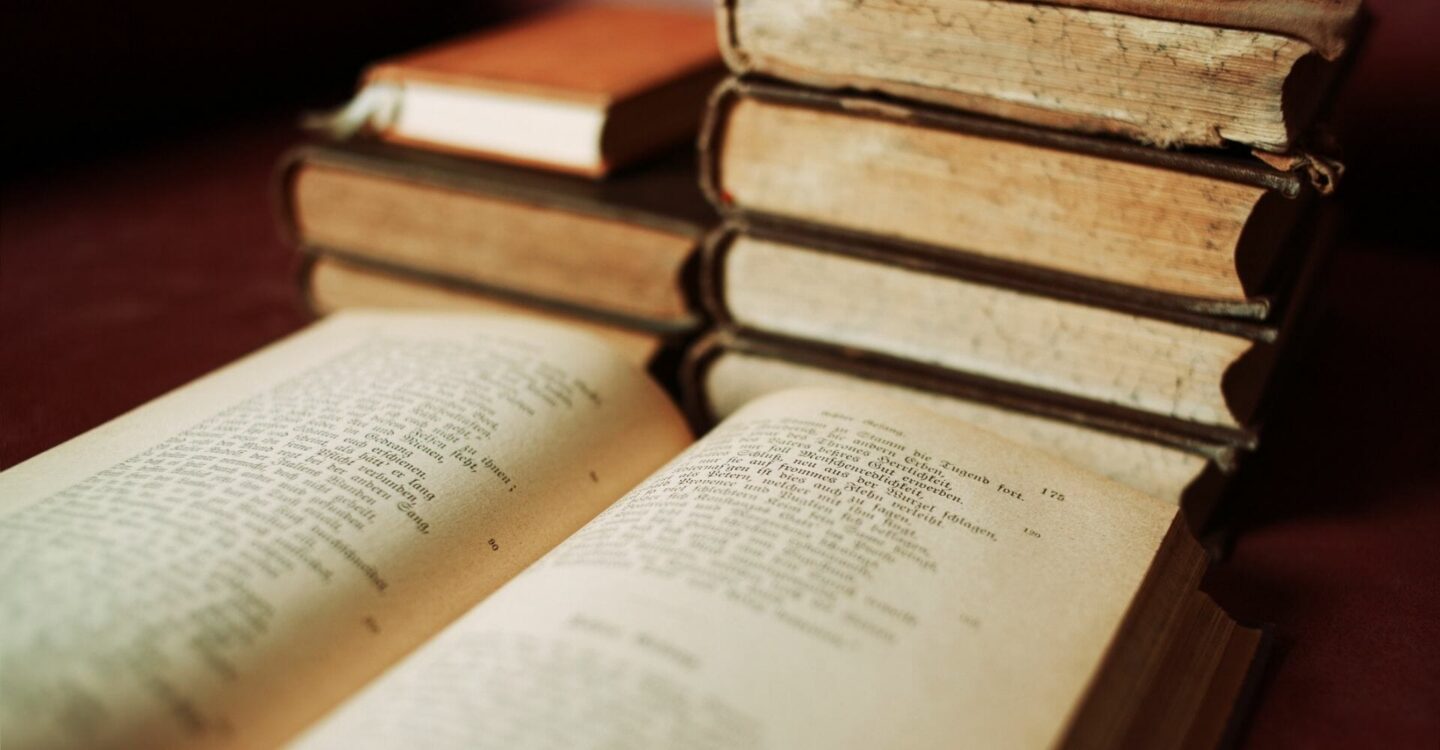DI EDOARDO VALENTE
Questa mia divagazione si fonda su due diverse affermazioni di Jorge Luis Borges: la prima riguarda Kafka e i suoi precursori, la seconda si riferisce al romanzo Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez.

In uno scritto intitolato Kafka e i suoi precursori Borges, con la sua solita arguzia, ci mostra un ragionamento tanto semplice quanto affascinante: “Ogni scrittore crea i suoi precursori. La sua opera modifica la nostra percezione del passato, come modificherà il futuro”.
Cosa vuol dire con questo?
Quello che ha fatto Borges per giungere a questa conclusione è stato presentare brevemente alcuni testi di autori estrapolati da culture e da epoche diverse tra loro, dimostrando come ognuno dei testi citati abbia qualcosa a che fare con l’opera di Kafka, anche se essi non hanno per forza qualcosa in comune tra loro.
Ciò significa, appunto, che è stato Kafka a creare i suoi precursori. Non sono autori che deve per forza aver letto, o che lo devono aver in qualche modo influenzato, ma il semplice mettere in relazione i suoi scritti con quegli altri fa emergere una somiglianza inevitabile, che però esiste solo ai nostri occhi.
“Se Kafka non avesse scritto” ci dice Borges “non lo avvertiremmo”. Per questo l’opera di un autore modifica il passato, creando connessioni tra punti lontani tra loro, ma che al nostro sguardo posteriore non appaiono poi tanto distanti.
Dunque, se è vero che ogni scrittore crea i propri precursori, come è possibile che esista un libro senza antenati?

È quello che mi sono chiesto imbattendomi in un’altra affermazione di Borges, che nella mia vecchia edizione di Cent’anni di solitudine è stata messa sul retro del romanzo, insieme all’opinione di altri nomi famosi.
La frase pronunciata da Borges si riferisce alla vittoria da parte di Márquez del premio Nobel per la letteratura, avvenuta nel 1982:
“Straordinario. Magnifico. È la scelta migliore che poteva fare l’Accademia svedese… Ho letto solo Cent’anni di solitudine. Ma posso aggiungere che questo libro basta… Si tratta di un libro originale, al di sopra di ogni scuola, di ogni stile e privo di antenati”.
Ecco, è stato quel “privo di antenati” a mettere in moto, nella mia mente, un collegamento con l’altro scritto di Borges in merito ai precursori, che mi ha portato di conseguenza alla presente riflessione.
Cent’anni di solitudine, o più in generale l’opera di Gabriel García Márquez, può essere priva di antenati?

È naturale pensare che, essendomi io posto una tale questione, la risposta che darò sarà “no, non è priva antenati”, ed è infatti ciò che vorrei dimostrare.
Certo, la mia cultura e la mia abilità critica non sono neanche lontanamente avvicinabili a quelle di Borges, che è riuscito a citare in ordine cronologico le diverse fonti dei “precursori” di Kafka, passando dalla Grecia antica alla Cina del IX secolo, da Kierkegaard a Browning, da Léon Bloy a Lord Dunsany.
I primi autori a cui vorrei fare riferimento, per iniziare a porre le basi di una genealogia dell’opera di Márquez, sono molto più didascalici e immediati.
Non è un mistero che Gabriel García Márquez si sia rifatto primariamente ai romanzi dello scrittore statunitense William Faulkner. La costruzione della storia attorno a una famiglia ben radicata in un luogo geografico, che non esiste nella mappa ma che è estremamente reale, la si può ritrovare tanto in Faulkner quanto in Márquez.
Si pone qui un primo antecedente. Lo stile di Márquez, poi, soprattutto nei dialoghi, pare sia stato influenzato dall’asciuttezza di Hemingway. Quest’ultimo, però, contemporaneo di Faulkner, da molti ne era considerato il rivale, poiché i loro stili letterari differivano sotto numerosissimi punti di vista.
Faulkner e Hemingway, dunque, non hanno nulla in comune tra loro. Ma hanno in comune il fatto di aver in qualche modo influenzato la scrittura di Márquez.

Altra importante eredità di Faulkner è l’utilizzo di un tempo non lineare, caratteristica narrativa che, però, si può far risalire alla tradizione del modernismo europeo (sulla cui scia, d’altronde, sia Faulkner che Márquez si sono inseriti).
Ciononostante, Márquez è universalmente ricordato per aver dato origine, all’interno della letteratura sudamericana, allo stile denominato “realismo magico”.
Questo stile si caratterizza per la presenza di elementi fantastici, surreali, magici appunto, in un contesto che non ne preannuncia dichiaratamente la presenza (come potrebbe fare un romanzo fantasy) e che senza quegli elementi specifici potrebbe essere considerato un’opera realista.
Eppure, anche in questo caso non basta dare una semplice spiegazione da manuale per capire di cosa si tratta, né è sufficiente sapere che questa tradizione è iniziata con Gabriel García Márquez per poter ammettere che non ha avuto dei precedenti.
Un grande precursore, indicato dallo stesso Márquez, è proprio Franz Kafka. La sua capacità di raccontare con estrema naturalezza eventi surreali, come se fossero la normalità, oltre a essere l’elemento straniante tipico dell’opera kafkiana, ha prodotto in Márquez il desiderio di replicare quello stile.
Lo scrittore colombiano, infatti, non si considerava appartenente a quel filone del realismo magico, che in qualche modo lui stesso ha iniziato, ma si considerava principalmente un realista. Questo perché la realtà è molto più sfaccettata, profonda, strana e immaginifica rispetto a quel che si crede, e quello che Márquez raccontava, stando alle sue parole, era nato più dal ricordo che dalla fantasia.
L’elemento “magico” della realtà non dipende solo dalla realtà stessa, ma da ciò che ognuno sceglie di vedere. Dipende dalla nostra capacità di conoscere “l’altro lato delle cose”, per citare una frase tratta proprio da Cent’anni di solitudine.
Il surreale è sempre stato presente mescolato al reale, nelle nostre vite, nelle nostre letterature, fin dall’inizio dei tempi.
È infatti quasi all’inizio dei tempi e della letteratura che vorrei puntare lo sguardo, pensando agli antenati di Cent’anni di solitudine. Borges ci ha detto che questo romanzo è anche “al di sopra di ogni scuola”, ma a me sembra, anzi, che Márquez sia andato a scuola dagli antichi.
Si parla, nel suo più celebre romanzo, della leggendaria fondazione di una città, del grande capostipite di una famiglia importante, di amori e guerre; ci sono persone che tornano dal regno dei morti, ci sono anticipazioni del futuro, ci sono riti e superstizioni; ci si rifà alla tradizione orale, per raccontare eventi incredibili.

Insomma, è presente un tratto epico, da poema epico, che mi fa ripensare all’Eneide di Virgilio.
Questo significa che Márquez si è ispirato a questo poema per la scrittura del suo romanzo? No, non è detto, anzi molto probabilmente non l’ha fatto. Eppure, in qualche modo, ciò che ha scritto appartiene a una scuola e ha degli antenati.
Le radici della sua opera, che sono ben radicate nell’America del Sud, arrivano ad attingere, in realtà, a una tradizione antica, mitologica. Non tanto perché sia questa la volontà di Márquez, ma perché questa è la conseguenza di ciò che ha scritto.
Viviamo sicuramente in un’epoca che ci impone spesso di cercare l’autenticità, l’originalità, e tutto ciò che possa staccarci dal passato, o da tutti gli altri: poter emergere in una massa uniforme.
Fare questa cosa, però, con l’intento di farla, è impossibile.
Ai nostri occhi Cent’anni di solitudine può apparire sicuramente come un’opera originale, ma Márquez l’ha scritta pensando alla tradizione orale della sua terra, agli scrittori che ammirava, alla sua stessa esperienza di vita.
Il “nuovo” non può esistere interamente, e anzi tentare di raggiungerlo con tutte le proprie forze implicherebbe sradicarsi a tal punto dalla tradizione umana da produrre qualcosa che, privato di umanità, perde per noi ogni tipo di interesse.
Non possiamo lamentarci del fatto che è stato già scritto tutto, perché questo era vero già dai tempi di Omero. Né dobbiamo impuntarci sull’originalità assoluta, la rifondazione completa, la novità ultima.


Apparterremo, sempre e in ogni caso, alla tradizione umana nella quale siamo nati, dalla quale abbiamo appreso ogni cosa, e ogni nostro gesto creativo, per quanto unico, non farà altro che ripetere la tradizione, accrescendola e rafforzandola.
Diventa scontata, ormai, la risposta alla domanda: “Può esistere un libro senza antenati?”.
No, non può esistere: l’intera storia umana ne fa da antenato, e questo non ha alcuna accezione negativa.
Così come può farci sorridere sapere che un certo movimento che facciamo con le mani, o la forma del nostro volto, deriva da un parente che mai abbiamo conosciuto; allo stesso modo un gesto creativo o la forma di un’opera d’arte non perderanno valore poiché non sono totalmente originali. Al contrario, potranno farsi forza grazie alla tradizione che portano con sé.
Se la ricerca culturale, artistica, umanistica, può servire a qualcosa, questa cosa è l’indagine delle nostre radici, delle nostre inaspettate parentele con l’insondabile passato.
Ogni novità è “figlia” di ciò che l’ha preceduta, per questo non conviene credere di potersi liberare da ciò che è stato: esso continuerà a vivere in ciò che esiste ora, in ciò che esisterà un domani.


Desideri leggere altri articoli di natura letteraria? Allora clicca qua sopra!!!
Desideri leggere un articolo che parla di narrazioni? Clicca qui!!!
Vorresti sentire l’intervista di un’autrice? Allora pigia qui!!!