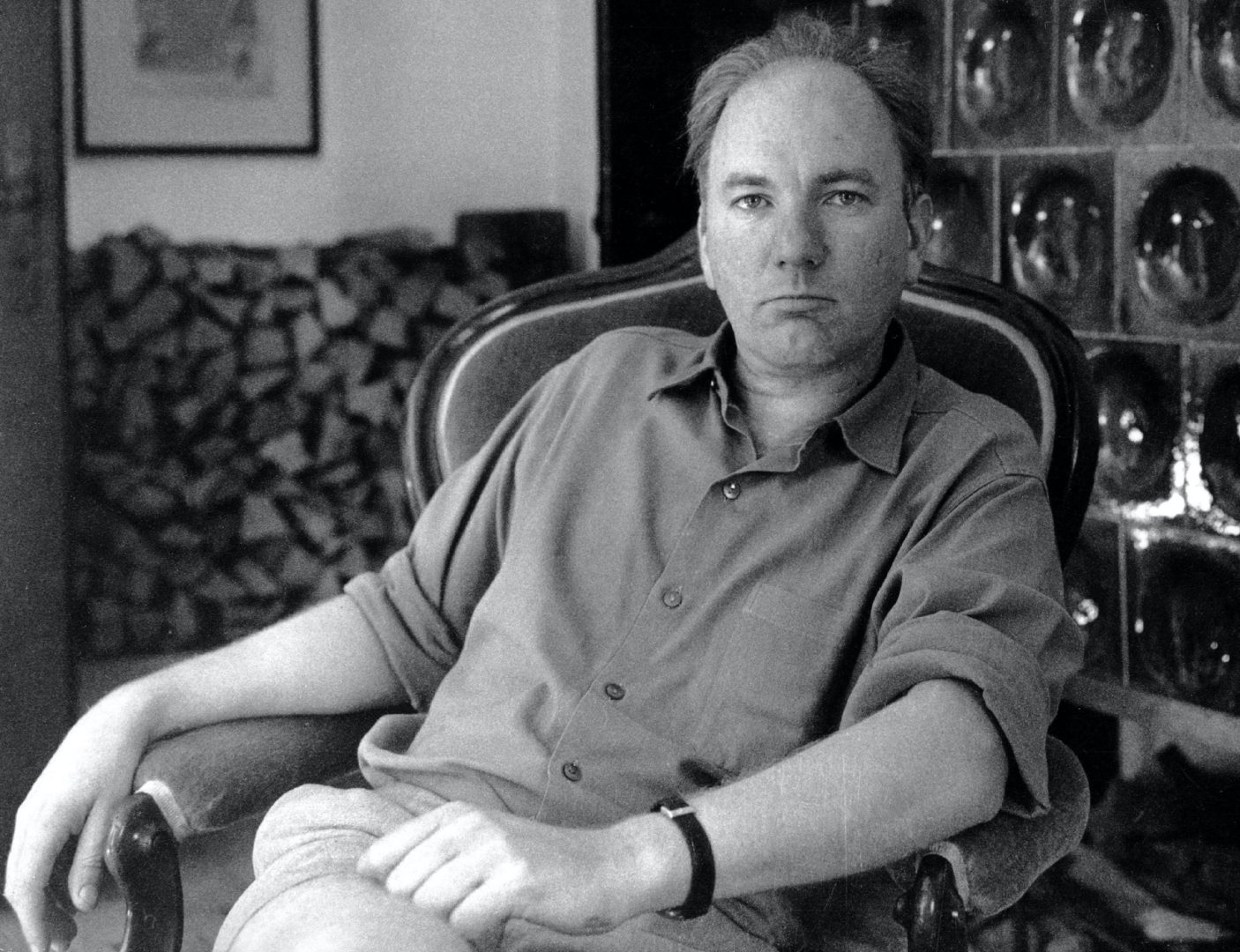DI EDOARDO VALENTE
[THOMAS BERNHARD: CHI ERA COSTUI? CLICCA QUA E SCOPRILO!]
[VUOI LEGGERE BERNHARDIANA I? ALLORA PIGIA QUI!]
Dopo il rifiuto da parte dell’editore di pubblicare la sua quarta raccolta di poesie, Thomas Bernhard, che si era per anni dedicato alla poesia, emerge con un romanzo omonimo alla raccolta rifiutata: Gelo.
Inizia così la sua carriera – la sua vita – di romanziere, di prosatore, che lo renderà uno dei più originali del Novecento.
In questo terzo articolo dedicato allo scrittore austriaco vorrei sezionare questa sua attività di romanziere, sorvolando vent’anni del suo operato, dal 1963, anno di pubblicazione di Gelo, al 1982, anno di pubblicazione dei romanzi brevi Cemento e Il nipote di Wittgenstein.
(Alle opere successive al 1982 dedicherò un altro articolo).
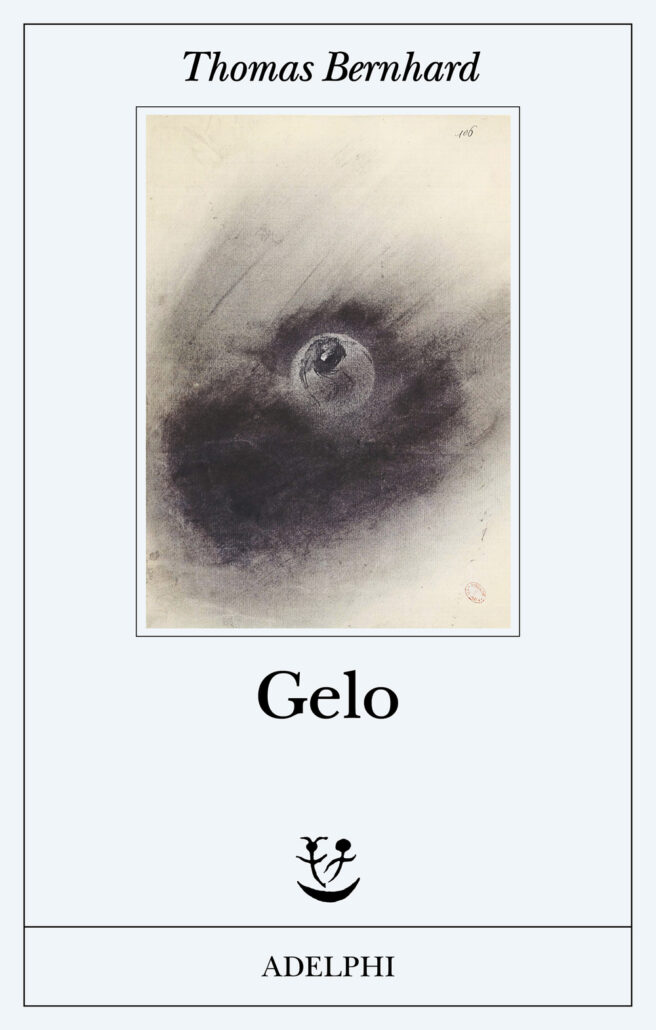
Le opere narrative di Bernhard (lo si notava anche nelle sue poesie) tendono a essere simili tra loro, tutte diverse sfaccettature di uno stesso nucleo centrale, un nucleo malato, fatto di ossessione, follia, vertigine, orrore, morte.
È dunque possibile muoversi con naturalezza tra un’opera e l’altra, trovare sovrapposizioni, insinuarsi in questi interstizi.
Gelo, nel suo essere un esordio, raccoglie i semi di quelli che saranno i tipici aspetti della narrativa bernhardiana. Un ragazzo, colui che dice io, il narratore della vicenda, viene incaricato di annotare i comportamenti del pittore Strauch, che sta in una locanda in un posto isolato tra le montagne.
E così come il narratore ci riporta parola per parola il monologare del pittore, venendo catturato dalla sua spirale, anche noi, leggendo Bernhard, ne veniamo catturati.
E accade la stessa cosa con il narratore di Perturbamento, in cui, specialmente nella seconda parte, siamo catturati tra le spire del monologo di un principe, isolato nel suo castello. E in La fornace abbiamo un “io” narrante che appare a malapena, e che riporta la vicenda di Konrad in continuo spostamento tra il discorso diretto e indiretto. Così come in Correzione ci viene riportato quello che Roithamer ha scritto in un manoscritto che col tempo diminuisce sempre di più.
La “correzione” a cui si riferisce l’omonimo romanzo è proprio quella che viene fatta nei confronti di quel manoscritto. Roithamer – docente di scienze naturali – vuole raccontare il rapporto con la famiglia e la casa di famiglia, da cui vuole allontanarsi sempre di più, e corregge continuamente il suo manoscritto, riducendolo sempre di più.
Il narratore di Cemento, anche lui scrive, un saggio su Mendelssohn, nell’isolamento della sua casa di campagna, ma viene interrotto dalla sorella, che lui stesso aveva invitato, poiché la scrittura di quel saggio, in un modo o nell’altro, diventa impossibile; così come accade ne La fornace a Konrad, che vuole scrivere un saggio sull’udito, che esiste nella sua mente, diviso in capitoli, e lui aspetta sempre il momento giusto per scriverlo, che non arriva mai.
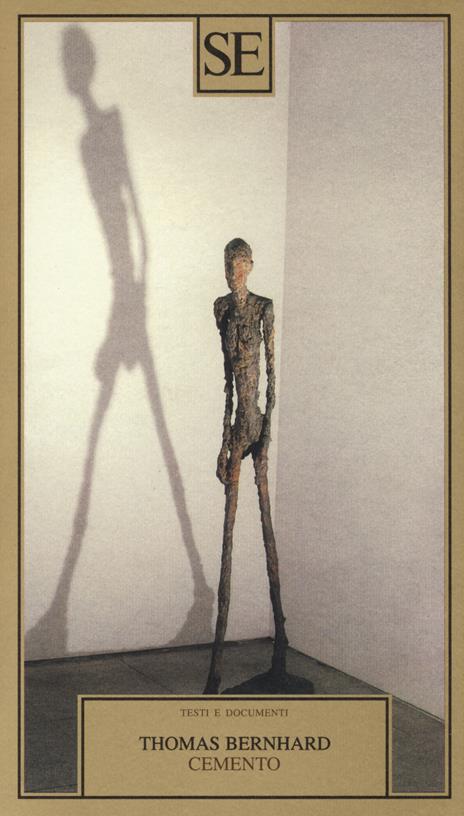
Per poter scrivere quel saggio ha anche deciso di isolarsi, insieme alla moglie, e di andare a vivere in una vecchia fornace.
I luoghi isolati, come questi manoscritti che non esistono, sono un fulcro fondamentale della narrativa di Bernhard.
Procedendo nell’ordine di pubblicazione dei libri da me citati per questa disamina, appaiono i seguenti luoghi:
Gelo (1963) si svolge principalmente in una locanda isolata tra le montagne;
Amras (1964) si svolge in una torre;
Perturbamento (1967), nella seconda parte, si svolge in un castello;
La fornace (1970) ha come luogo principale la fornace;
Correzione (1975) ha come luogo principale una casa su un fiume, la sua soffitta, ma fondamentale è anche un altro luogo: una struttura conica nel cuore della foresta;
Cemento (1982) è l’unico ad avere uno spostamento: il narratore, non potendo scrivere nell’isolata casa di campagna va a Palma di Maiorca, dove neppure lì potrà scrivere;
Il nipote di Wittgenstein (1982) si svolge in una clinica viennese.
I luoghi sono fondamentali per Bernhard, rappresentano perfettamente la prigionia dei narratori, dei protagonisti, che sono prigionieri della loro stessa follia, ossessione, paranoia.
Ripartiamo dalla fine: Wittgenstein è un’altra ossessione di Bernhard, tanto da metterlo nel titolo di un libro, Il nipote di Wittgenstein, in cui racconta la sua amicizia, all’interno della clinica, con Paul Wittgenstein, nipote del celeberrimo filosofo Ludwig Wittgenstein.
Filosofo citato più volte negli scritti di Bernhard, e che ha un ruolo paradossale nel racconto impossibile Goethe muore, in cui il grande poeta romantico tedesco, in punto di morte, esprime come ultimo desiderio quello di incontrare proprio Wittgenstein, che sarebbe nato cinquantasette anni dopo la sua morte.
E l’ombra di Wittgenstein infesta anche il vero protagonista di Correzione, Roithamer, che pare sia fortemente ispirato alla figura del filosofo viennese. Roithamer (così come fece Wittgenstein) vuole progettare una casa per la sorella, ma nella finzione bernhardiana, la casa è unica nel suo genere, mai vista prima, poiché a forma di cono.
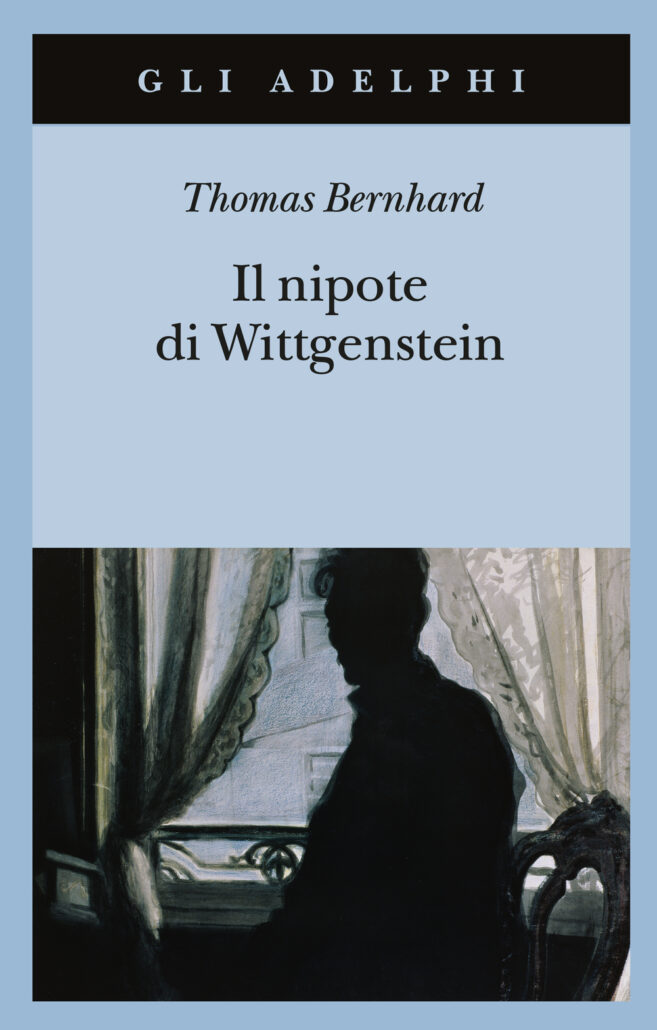
Ma l’ossessione di Roithamer per la costruzione del cono per la sorella, che giunge infine a compimento, lo porta alla disperazione nel momento della morte di lei, che coincide con il completamento del cono; una tragedia che causa una tragedia, poiché Roithamer decide a quel punto di suicidarsi.
E purtroppo anche il suicidio è un tema ricorrente nell’opera di Bernhard.
“Dopo il suicidio dei nostri genitori siamo stati rinchiusi per due mesi e mezzo nella torre, emblema di Amras, …”.
In questo modo struggente si apre il romanzo breve Amras, con il fallimento di un suicidio familiare premeditato: tutta la famiglia sarebbe dovuta morire, invece sopravvivono i due figli adolescenti, uno dei quali ci racconta l’allucinante vicenda.
Isolamento, ossessione, suicidio, malattia; l’oscurità nella natura attorno a noi e l’oscurità dentro di noi.
Questo è ciò di cui parla Bernhard. E con la sua scrittura, che diventa sempre più vorticosa, torrenziale, inevitabile, lo fa con estrema spietatezza.
Riassumere questa sua capacità, come io ho tentato di fare, è di per sé inutile. Sapere “di cosa parla” un romanzo di Bernhard è come sapere che una diga si è rotta. Il punto non è quello, ma è rendersi conto della potenza distruttiva, annientante, totalizzante, dell’esplosione di acqua che ci porta via, e noi dobbiamo assecondare la corrente, e solo così possiamo capire cosa significa davvero che la diga si è rotta.
Venire investiti e sommersi da questa scrittura resta, inevitabilmente, l’unico modo per comprenderla.
E comprenderla richiede sforzo, fatica, sacrificio.
Ci si potrebbe anche chiedere: “Ha senso sforzarsi, sacrificarsi, per leggere le parole spietate di un disperato che ci parla dell’inevitabile condizione disagiata in cui ci troviamo?”.
No, non per forza, potrebbe non avere senso.
Bernhard non ci intrattiene, non ci consola, non ci mostra il senso di qualcosa o di qualcos’altro, non ci dà ragione. Esatto, non ci dà nulla. Ma aiuta a togliere, a eliminare, a limare il nostro sguardo, ad affilare il pensiero, a liberarci di qualcosa, lo porta via nel turbine delle sue parole.
Cosa resta dopo il passaggio dell’alluvione?
Tutto è distrutto, tutto è perduto. Tranne l’essenziale.
La scrittura di Bernhard è l’alluvione che ci libera dall’eccesso, che ci sottrae anche molta bellezza, gioia, spensieratezza. Ma quel che resta ha un valore diverso, prezioso.
Bisogna scegliere se vale la pena di accettare l’inondazione. Tu che sei un albero, accetteresti di venire sradicato dal fiume in piena?
Quasi mai ne vale la pena.
Ma l’albero che non sopporta le proprie radici non attende altro.
Bernhard parla a te, che non aspetti altro che venire sradicato.
Thomas Bernhard: chi era costui? Clicca qua e scoprilo!!!
Vuoi leggere Bernhardiana I? Allora pigia qui!!!
Desideri leggere altri articoli di natura letteraria? Allora clicca qua sopra!!!